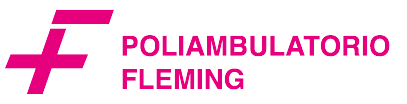Neurochirurgia
I nostri professionisti

Prestazioni ed Esami
- Patologie della colonna vertebrale (sciatalgia, lombalgia, ernie del disco, stenosi del canale lombare, spondilolistesi, discartrosi cervicale, fratture vertebrali)
- Patologie vascolari del sistema nervoso centrale (aneurismi, cavernomi, malformazioni vascolari, fistole arterovenose)
- Patologie tumorali del cervello e del midollo spinale (gliomi, meningiomi, neurinomi, adenomi ipofisari, tumori extramidollari ed intramidollari)
- Idrocefalo
- Sindromi da conflitto neurovascolare (nevralgia del trigemino, emispasmo facciale, nevralgia del glossofaringeo)
- Chirurgia mini-invasiva e radiochirurgia
- Trattamento della nevralgia del trigemino
© 2024 Poliambulatorio Fleming - Tutti i diritti riservati - Direttore Sanitario Dott. Daniele Bianchi - P.IVA 04346430277